
A cura del Settore orientamento e informazioni bibliografiche
Ridere nell’Antica Roma / Mary Beard
A partire da questo numero la rubrica "Suggerimenti di lettura" è curata da Fulvia Maniori, coordinatrice del gruppo di lavoro cui è affidata la gestione dei servizi di orientamento e prima assistenza del pubblico della nostra biblioteca.
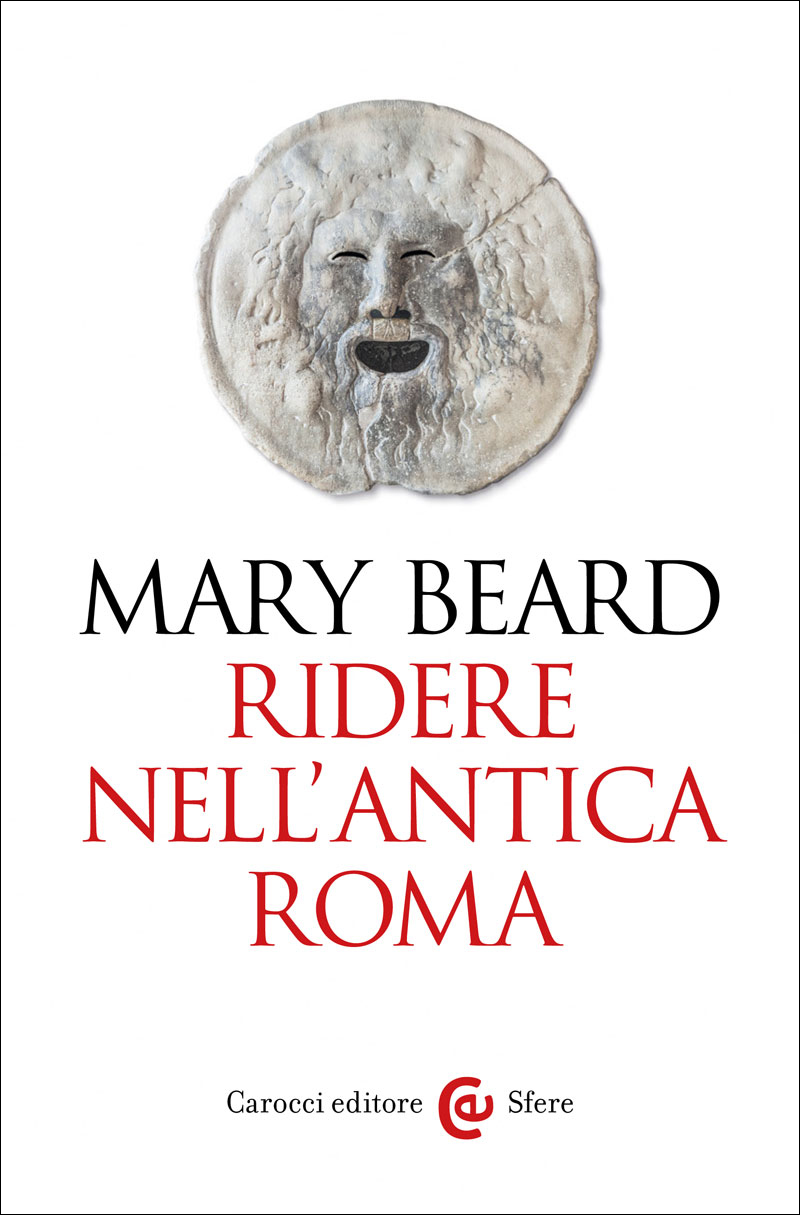 Mary Beard (Much Wenlock, Shropshire, 1955), cattedra di Antichità classiche all'Università di Cambridge, è un raro caso di insigne e colta personalità accademica, divenuta molto popolare, anche tra i non specialisti, grazie ai suoi numerosi interventi sui media (la lunga collaborazione con la BBC) e al modo sottile, provocatorio e anticonvenzionale, e insieme seduttivo, di ristudiare e riproporre la storia romana antica. Il suo ultimo libro Ridere nell'Antica Roma, pubblicato originariamente in inglese nel 2014 con il titolo Laughther in Ancient Rome: on joking, tickling, and cracking up e tradotto ora in italiano per Carocci (2016), è un saggio di storia culturale, in cui questa «classicist with the common touch», secondo la felice definizione di The Guardian, conduce per vie inusuali il lettore dentro i meccanismi fondamentali del comportamento sociale e politico dell'uomo romano, ricercando e osservando in contesto un indicatore apparentemente marginale e senz'altro "scivoloso" all'analisi, che costituisce nello stesso tempo un determinante dell'identità umana di ogni tempo e di ogni luogo: il riso.
Mary Beard (Much Wenlock, Shropshire, 1955), cattedra di Antichità classiche all'Università di Cambridge, è un raro caso di insigne e colta personalità accademica, divenuta molto popolare, anche tra i non specialisti, grazie ai suoi numerosi interventi sui media (la lunga collaborazione con la BBC) e al modo sottile, provocatorio e anticonvenzionale, e insieme seduttivo, di ristudiare e riproporre la storia romana antica. Il suo ultimo libro Ridere nell'Antica Roma, pubblicato originariamente in inglese nel 2014 con il titolo Laughther in Ancient Rome: on joking, tickling, and cracking up e tradotto ora in italiano per Carocci (2016), è un saggio di storia culturale, in cui questa «classicist with the common touch», secondo la felice definizione di The Guardian, conduce per vie inusuali il lettore dentro i meccanismi fondamentali del comportamento sociale e politico dell'uomo romano, ricercando e osservando in contesto un indicatore apparentemente marginale e senz'altro "scivoloso" all'analisi, che costituisce nello stesso tempo un determinante dell'identità umana di ogni tempo e di ogni luogo: il riso.
Come "funzionava" il riso a Roma, inteso innanzi tutto come pratica reale? Poteva il ridere, nella sua complessa sintassi comunicativa e relazionale, non solo rispecchiare, ma addirittura fungere da regolatore delle dinamiche sociali? Cosa pensavano i romani del riso? E, infine, cosa condividiamo noi oggi del riso dei romani?
Che il progetto sia tanto attraente quanto immane lo dichiara la stessa Mary Beard: difatti, il ridere si rivela, fenomeno o fatto, tanto minutamente declinabile quanto sfuggente, un composto inestricabile di nature e di cause diverse e mutevoli, in bilico tra istintività e linguaggio, tra spontaneità e codice, la percezione delle quali cambia al cambiare delle convenzioni culturali e delle peculiarità individuali di chi lo interroga. Questa precaria, sconfortante e insieme affascinante, parzialità di ogni discorso sul riso è messa in luce in modo straordinario da Mary Beard, che la assume come fondamento metodologico e strategia espositiva: rari saggi scientifici contengono un così elevato numero di domande e un così elevato numero di risposte a domanda egualmente vere o possibili o mute, rare ricostruzioni storiche presentano maglie così aperte e uno stile tanto interrogativo e interlocutorio. "Il mio obiettivo è fare del riso a Roma un argomento più complesso o, per meglio dire, più ingarbugliato che ordinato": l'adozione di tale approccio euristico non semplificato, che rinuncia agli inquadramenti unitari e sistematici (l'autrice ne ripercorre i principali tentativi del passato nei capitoli 2-4), ma rappresenta, in modo quasi mimetico, la dimensione, la densità e insieme l'inafferrabilità del proprio oggetto, è anche una coraggiosa, eccezionale provocazione diretta ad ogni tipo di ricerca che speri di cogliere i tratti dell'umano.
Il libro si compone di due parti: alla prima, speculativa e metodologica, danno corpo le discussioni notturne svoltesi nei caffè di Berkeley a margine delle Sather Lectures tenute all'Università da Mary Beard nell'autunno 2008; il programma di queste ultime, invece, alcuni "faccia a faccia" con aspetti particolari del riso romano, sono argomento della seconda.
Serve da introduzione un capitolo (Capitolo 1) che è utile adottare come filo di Arianna attraverso il "caos", perché attorno a due soli esempi consente di coagulare le questioni di base e alcune coordinate essenziali della cultura del riso a Roma, esaminate poi a fondo ed in straordinaria articolazione di casi e riflessioni, tra testi inusuali e figure altrimenti note - politici e imperatori, mimi e buffoni, meretrici, scultori, oratori e scimmie -, nei capitoli successivi.
Mary Beard presenta l'erompere in situazione (questo interessa, infatti: «Il riso, non lo humour, lo spirito, la satira, l'epigramma, la commedia», dunque il ridere come atto di comunicazione nel contesto reale delle relazioni in cui si manifesta, «le sue cause, i suoi contenuti, i suoi bersagli e le sue conseguenze») di due antiche risate: l'una, vera, dello storico Cassio Dione, soffocata masticando alloro all'esibizione dell'imperatore Commodo, mentre, ghigno in volto, agitava una testa sgozzata di struzzo davanti ai banchi dei senatori al Colosseo, nel 192 d.C.; l'altra, di palcoscenico, risuonata («hahahae!») per la prima volta sul Campidoglio nel 161 a.C. in occasione delle Megalesie, rappresentata nel suono - fatto rarissimo nella letteratura antica - sul copione dell'Eunuco di Terenzio e messa in bocca al parassita Gnatone in risposta ad una battuta, riciclata, del suo patrono Trasone, nel corso di un banchetto.
Entrambe le situazioni fanno intravedere come il riso entri nelle dinamiche dei rapporti di potere come segno e come determinante (al ghigno intimidatorio dell'imperatore, il senatore risponde mascherando un moto di riso teso, ribelle e derisorio; alla trita battuta del suo patrono, il parassita Gnatone risponde esibendo un riso adulatorio, che forse dissimula canzonatura); inoltre, come esso possieda una funzione centrale nella pratica e nella rappresentazione delle diseguaglianze insite nell'ordine sociale romano e delle interazioni sociali, intese particolarmente in senso gerarchico (imperatore e sudditi, parassita e patrono, ma anche padrone e servo, se solo si pensa alla trama di molte commedie latine); infine come eserciti una forte funzione inclusiva o esclusiva rispetto ad un gruppo, anche di natura temporanea (i senatori, i conviviasti). Un'opposizione tra spontaneità incontrollabile (quella di Dione) e convenzionalità del riso (quella di Gnatone, che ride alla battuta per il proprio ruolo sociale) si pone anche in evidenza e, in particolare, come strettamente legata, da un lato, alla preoccupazione per la sua sorveglianza culturale e politica (il riso irrefrenabile e auto-represso di Dione sottintende la capacità di sanzione da parte del deriso), dall'altro, al problema della sua sostanza di verità o di falsità (nei meccanismi adulatori della subalternità e del patrocinio e nell'ambito dell'istituzione conviviale il ridere, così come il provocare riso con battute e storielle, diventa parte di un sistema di scambio "economico" atteso e consapevole). L'episodio conviviale di Gnatone, la figura e le modalità di interazione del parassita/buffone aprono, infine, un'ulteriore prospettiva sulla presenza di professionisti del riso attivi a Roma dentro aggregati sociali, in particolare di élite, sulla loro funzione e sul loro posto all'interno del sistema di valori culturali generali.
A tutte queste questioni, inerenti la funzione politica e di marcatore gerarchico del riso, qui abbozzate attraverso le due risate introduttive, è dedicato estesamente il capitolo 6 del libro (Da imperatore a buffone), attraverso il quale emerge in modo vivo come la pratica del riso, in quanto pratica sociale, sia non solo connessa strettamente alla pratica del potere («L'autocrazia romana era immersa nella cultura del riso e della facezia»), ma concorra anche a definirne i "differenziali": sul parametro del riso, il romano distingueva il buon governante (benevolo nello scherzo, autocontrollato nel proprio e tollerante di quello altrui) dal tiranno (aggressivo e sregolato nel proprio, repressivo e regolatore di quello altrui), in una lunga galleria tracciabile di paradigmi, tra gli estremi opposti di Augusto ed Eliogabalo e Caligola, attraverso Claudio.
Altro, delicatissimo, aspetto del controllo del riso (ma da parte di chi lo provoca rispetto al suo pubblico) e della sua sincerità (di chi lo esprime, riguardo al proprio obiettivo) è quello della sua "fragilità", intesa come vulnerabilità di chi lo produce ad esserne, per rovesciamento indesiderato e spesso inconsapevole, anche oggetto o bersaglio, ambigua transitività che anche l'aggettivo latino ridiculus esprime, per aver significato tanto attivo (divertente) quanto passivo (ridicolo). Così è nei due esempi citati di Commodo e di Trasone. Ma le complesse dinamiche di questo rovesciamento vengono approfondite da Mary Beard in particolare connessione ai rischi dell'uso dello scherzo all'interno dei discorsi politici e giudiziari, materia del capitolo 5 (Oratore), dedicato quasi interamente a Cicerone - del quale è offerto un ritratto sorprendente di umorista temibile e tagliente, ben diverso dal grave e prolisso retore a cui siamo abituati («il più famigerato autore di burle, giochi di parole e facezie dell'antichità classica») - e in cui si affronta anche il tema della teorizzazione romana sul riso (il II libro del De oratore e l'Orator, di Cicerone e l'Institutio oratoria di Quintiliano). Senza entrare nei tentativi di definizione generale (in realtà, anche per i romani il riso era irriducibile a regole rigide), si evince che ciò che faceva specialmente ridere a Roma era la sottolineatura comica dell'«alterazione fisica nelle sue diverse forme», sia naturale (le battute sulla calvizie o sui gobbi o sui bassi) sia riprodotta in forma di caricatura (dalla mimica facciale, alla voce, al modo di usare il corpo), e che l'imitazione era un fattore fondamentale del riso romano. Ma se tale strumento era efficace per suscitare una risata, costituiva nello stesso tempo un rischio, perché, non equilibratamente gestito, poteva colpire il soggetto che lo utilizzava, anziché il bersaglio verso il quale lo si voleva indirizzare. Qui entrambi i teorici pongono un confine per l'oratore di qualità rispetto al mimo o allo scurra, attori "persuasivi" rispetto al riso, ma socialmente disprezzati, e le modalità del cui umorismo, contraddistinto dalla volgarità e dall'eccesso, dalla mercificazione e dalla ricerca voluta della risata, dalla genericità decontestualizzata delle battute preconfezionate e dalla generale connotazione ridicola in senso passivo, fungono da parametro negativo assolutamente da evitare (sullo scurra, le p. 169-172 del capitolo 6; per il mimo, le p. 184-190 del capitolo 7).
Il ghigno di Commodo, rappresentazione del riso umano deformato in smorfia e quasi rumore, oltre a riflettere le questioni di gerarchia e del ridiculum viste sopra, interne all'élite socio-politica maschile romana, conduce la riflessione a diverse distinzioni di genere e, segnatamente, al confine, nel riso, tra uomo e animale. La percezione di tale linea è in senso paradossale, sia in quanto il riso identifica l'uomo e contemporaneamente lo può portare al di sotto dell'umano (nelle Metamorfosi di Ovidio, il passaggio dal risus al rictus, dal riso al muso, è di norma il segnale della trasformazione fisica dell'individuo in bestia), sia in quanto la particolare provocazione alla risata, per i romani, di alcune specie distinte (scimmie e asini) è proprio in virtù della loro capacità imitativa dei comportamenti umani. Questi aspetti sono tema al capitolo 7 (Tra umano e animale (specialmente scimmie e asini)), di cui un'ampia sezione è dedicata tra l'altro alla complessa sintassi del ridere nel romanzo apuleiano Le metamorfosi (o L'asino d'oro), al cui inizio, paradosso di senso contrario, piace ricordare il collocarsi della festa del dio Riso, paradigma geniale della natura metalogica e autoriflessiva del nostro oggetto.
Un'ultima questione che gli esempi-campione sollevano è quella della comprensibilità del riso romano oggi. Mary Beard dedica diverse pagine per spiegare al lettore moderno, ricorrendo a filologia, storia e psicologia, la spiritosaggine dell'Eunuco detta da Trasone, che suscitò tanta ilarità nel suo parassita, nel pubblico di conviviasti interno alla scena e, presumibilmente, anche nel pubblico esterno che assisteva alla commedia - e probabilmente in ciascuno di questi per motivi diversi (la condivisione del riso non comporta necessariamente una condivisione delle sue cause): durante un banchetto, ad un avversario in amore, il soldato racconta di aver indirizzato questa battuta, datata, ma che spaccia per propria: «Sei tu una lepre, e vai cercando prelibatezze?», traduzione letterale che Mary Beard rende più appetibile al gusto contemporaneo in: «Sei tu stesso un manicaretto, e vai cercando un bocconcino?».
Queste operazioni di ritocco, sia verbale (dalla trasposizione in linguaggio moderno fino alla revisione filologica del dettato testuale) sia interpretativo (il processo stesso dell'analisi altera avvicinando e attualizzando) rendono sensibile il confine tra estraneità e familiarità dello humour antico. Ma è anche tangibile il fenomeno inverso della sua trasmissibilità, della sua tradizione attiva fino ai nostri giorni: dell'efficacia dello stesso riso e degli stessi canali del riso attraverso i secoli, forse resi possibili in virtù di una miriade di incessanti riletture e riadeguamenti culturali. Probabilmente a nessuno oggi strapperebbe una risata una storiella su un corridore crocifisso («Adesso non corre più, vola»), ma il politico britannico Enoch Powell ritenne di poter utilizzare per gioco, in risposta ad un barbiere troppo loquace, una vecchia freddura latina: «Come vuole che li tagli, signore?» - «In silenzio».
Questi aspetti, con i loro molteplici problemi, sono trama dell'ultimo capitolo del libro (L'amante del riso), il cui filo è la tanto famosa quanto complessa, per redazione e natura, antologia di facezie intitolata Philogelos, scritta in greco tra il IV e il V sec. d.C., forse esempio di repertorio ad uso di professionisti del riso e possibile primo testimone della nascita proprio a Roma della barzelletta in senso moderno, oggetto discorsivo decontestualizzato che si basa sul tipico e capace, proprio per questo, di viaggiare attraverso il tempo. Questa possibile maternità lo stesso lessico latino la conferma, ricco oltre misura di termini denotanti ciò che suscita il riso in forma di motto e battuta e, pertanto, un interesse enfatico per la sua provocazione in forma discorsiva, ma sorprendentemente poverissimo di parole che lo indichino in sé, il ridere, nel tanto come anche nel poco, fino all'assenza assoluta, sul piano lessicale e della rilevanza culturale, del sorridere.







