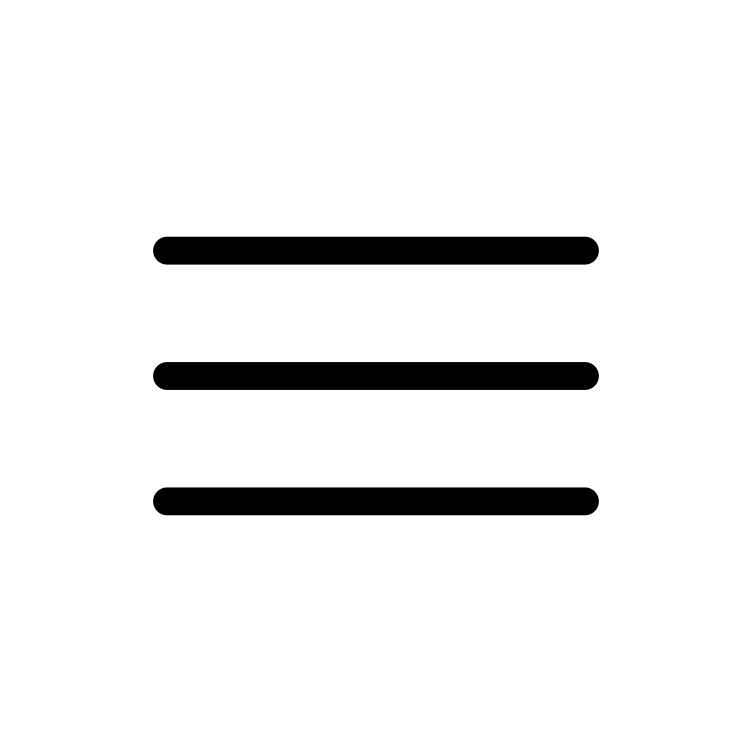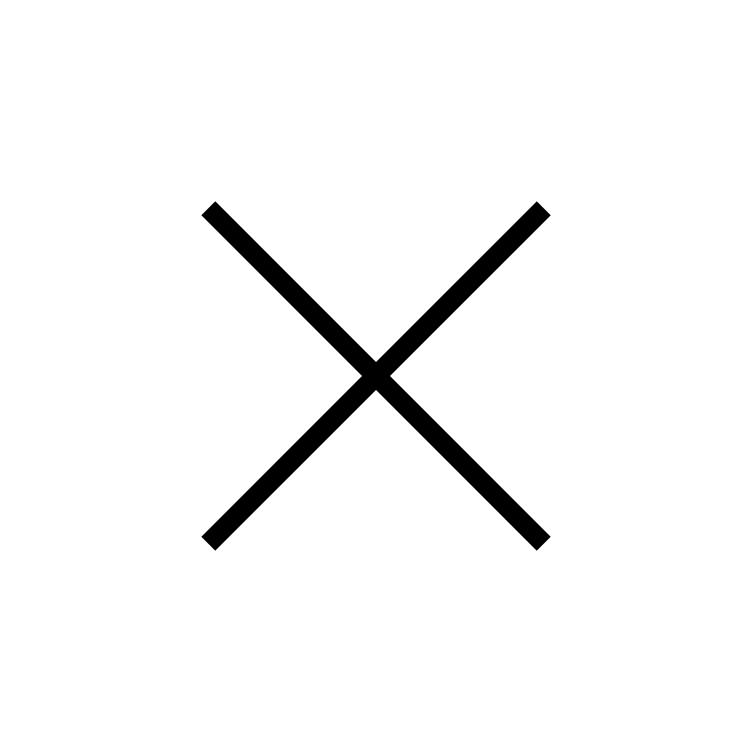Presentazione del libro "Liberare la libertà"
Rivolgo un saluto particolarmente cordiale agli illustri oratori, alle Autorità e ai gentili ospiti che con la loro presenza onorano il Senato. Il 13 maggio 2004 l'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Joseph Ratzinger, tenne proprio in Senato la Lectio magistralis sulle radici cristiane dell'Europa.
Nell'anniversario di quell'incontro, viene oggi presentato il volume "Liberare la libertà", che ripercorre le tappe fondamentali della riflessione di Benedetto XVI tra fede e politica nel terzo millennio, con un testo inedito del Papa Emerito inviato il 20 settembre 2014 a Marcello Pera, già Presidente del Senato.
Ho avuto modo di leggere e approfondire i contenuti del volume e mi propongo di limitare il mio intervento ad alcune considerazioni essenziali, con una avvertenza preliminare che ritengo necessaria. Vi è un rapporto dialettico e non statico tra autore e lettore. La pagina scritta vive nel cuore e nella mente di chi legge attraverso la comprensione, l'interpretazione, il commento che inevitabilmente derivano dalla formazione e dalle storie personali dei lettori. Anche nel mio caso la comprensione, l'interpretazione, la riflessione sul volume che viene oggi presentato risentono di una specifica lente di ingrandimento che è quella del diritto, che per esperienza personale, professionale ed istituzionale connota inevitabilmente la mia breve introduzione.
Il rapporto tra religione e Stato, da un lato, e fede e politica, dall'altro, gravita attorno ad una polarizzazione che nell'età moderna si è affermata come distinzione tra "dogma" e "storia".
Nella tradizione del diritto romano, tale contrapposizione non esisteva, perché l'ordinamento giuridico non era un prius rispetto alla dinamica di svolgimento dei rapporti tra individui, ma si definiva ed emergeva come regula juris proprio dal riconoscimento che soggetti pubblici e privati attribuivano ai singoli comportamenti. Ecco perché - come opportunamente affermava Rudolph von Jhering - "non tutto ciò che accade è storia", in quanto diventa storia, cioè diritto, quando è riconosciuto, accettato, e, solo alla fine, prescritto o vietato.
La scissione tra "dogma" e "storia", assente nella tradizione del diritto romano, ha invece assunto i tratti di una vera e propria ideologia in epoca moderna e ha trovato l'espressione più marcata nell'idea di positivismo giuridico che ha connotato fino ai nostri giorni la riflessione dei giuristi, ben al di là della stessa impostazione originaria di Kelsen. Contro tale ricostruzione, soprattutto a partire dal Novecento, è emersa una differente interpretazione del fenomeno giuridico inteso come esperienza, realtà di vita, mutuo riconoscimento di princìpi e valori.
La riflessione di Benedetto XVI si colloca in un ambito distinto: quello teologico, filosofico, esistenziale, parallelo rispetto alla dialettica che ha visto contrapporsi le impostazioni giuridiche di stampo giuspositivistico e giusnaturalistico, a quelle connotate dalle diverse declinazioni che il realismo giuridico ha assunto nel corso del ventesimo secolo.
Benedetto XVI supera la logica della scissione, della segmentazione dei saperi e delle esperienze, dimostrando come "dogma" e "storia" non si collochino al di fuori della realtà (comunque la si voglia declinare). Per un giurista è davvero dirimente cogliere il significato del diritto e della giustizia come movimenti non relegabili, alternativamente, alla sfera dell'"aldilà" ovvero dell'"aldiqua", perché come ci suggerisce chiaramente Joseph Ratzinger, il punto cruciale è superare la finzione che divide il mondo reale secondo categorie di pensiero o, peggio, lo stesso pensiero, dalla realtà. In altri termini, il dogma vive dentro la storia ed è la storia a rivelare il dogma, rendendo giustizia a ciò che è vero rispetto a ciò che è falso.
L'impostazione di Benedetto XVI ha una ricaduta diretta nella stessa definizione di "soggetto di diritto". Come è noto, nel diritto romano classico, non tutti gli individui sono soggetti di diritto e titolari di capacità giuridica. Diversamente dalle esperienze contemporanee, il diritto romano in definitiva considera lo stesso uomo come "oggetto di diritto", a capacità giuridica relativa al suo specifico status personae.
In questo caso il pensiero moderno e contemporaneo disvela la contraddizione degli antichi e propone di considerare l'uomo non come oggetto, bensì, sempre e comunque come "soggetto di diritto".
La riflessione portata avanti nel corso della sua intera vita da Joseph Ratzinger chiaramente indica come la logica della scissione e della discontinuità oltre ad essere fallace sul piano logico, si rivela altresì incoerente rispetto a quello fattuale. Dogma e storia non sono scindibili, così come è fuorviante ridurre l'uomo a essere considerato in modo parziale semplicemente oggetto o soggetto di diritto. La traduzione giuridica di tale impostazione può così sintetizzarsi. L'auctoritas dello Stato contrapposta alla libertas dell'individuo nega il fondamento del diritto come giustizia, mentre il riconoscimento da parte dello Stato della "persona" come limite dell'azione pubblica diventa la giustificazione, la legittimità, la legittimazione delle Istituzioni e più in generale degli ordinamenti giuridici.
In uno scritto del 384 d.C. che non esiterei a definire straordinario, San Gerolamo racconta di un sogno durante il quale di fronte al Tribunale del Giudice egli veniva interrogato su quale fosse la sua identità. Nel sogno egli rispondeva di essere "un cristiano". Ma il Giudice così sentenziò: "Tu menti, tu non sei cristiano, ma un ciceroniano, perché laddove è il tuo tesoro, là è il tuo cuore". In un altro scritto lo stesso Gerolamo affermava: "aliae sunt leges Caesaris, aliae Christi, aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecepit".
Cosa significa contrapporre l'essere cristiano e l'essere ciceroniano? Significa spezzare l'unitarietà del pensiero e della vita concreta rispetto alle ideologie.
Ratzinger fin dalla fondamentale "Introduzione al Cristianesimo" del 1968, dimostrava l'incoerenza di una statualità intesa in modo assoluto, di una ideologia sinonimo di fede e di una fede derivata dalla ideologia. L'attualità di quella intuizione resta intatta: distinguere fede e politica, stato e individuo è tanto necessario quanto riconoscere che la politica non possa concepirsi al di sopra, ma sia calata dentro il "giudizio della ragione, che è la madre del diritto", secondo la nota affermazione di Federico II di Svevia.
Ed è dirompente la provocazione di Ratzinger che già nel 1968 afferma: "Dio è pratico". È evidente, nella sua riflessione la correlazione proposta da Romano Guardini tra verità e giustizia: "da ciò che è vero nasce quanto è giusto".
Per il giurista, per un rappresentante delle Istituzioni, per il cittadino questa provocazione ha un significato concreto: viviamo nell'età dei diritti, ma la persona diventa pienamente soggetto di diritto proprio quando assume su di sé la logica del dovere.
Il processo di Gesù di fronte a Pilato fa emergere la centralità della domanda: "che cosa è la verità?", ma non supera l'altro interrogativo fondamentale "che cosa è la libertà?".
Alfonso Maria De' Liguori riconosce che "la libertà è il requisito necessario della moralità", ma è proprio sulla linea di confine tra verità, libertà, moralità che Religione e Stato sono chiamate a confrontarsi e riconoscersi nella logica dei diritti umani, che per definizione supera l'idea di "confine" e si proietta verso quella di "universalità".
Nella lettera inedita del Papa Emerito si propone dopo Sant'Agostino di recuperare appieno il pensiero di Aristotele. Questa non è solo una notazione, ma un varco ineludibile sia per i cittadini sia per i loro rappresentanti politici. Non c'è diritto senza dovere; non c'è ordinamento giuridico senza giustizia; non c'è verità senza libertà e viceversa. Questo significa che non è possibile votare sulla verità e allo stesso tempo che non è possibile negare la libertà, che il "potere" non può sostituirsi al "sapere", in definitiva che le azioni degli individui e le decisioni delle Istituzioni devono fermarsi di fronte all'idea di "persona", che non è più solo "appartenenza" ad una singola Religione o ad un singolo Stato, ma "identità" imprescindibile e irrinunciabile per ogni Religione e per ogni Stato.
Concludo riprendendo dal punto iniziale della mia introduzione. Per il grande giurista Pietro Bonfante, il diritto romano universale - jus gentium - venne superato dalla influenza dell'Oriente ellenistico in quello che definì diritto elleno-romano. Per un altro grande giurista come Salvatore Riccobono, invece, il superamento del jus gentium avvenne con l'emersione del diritto romano-cristiano.
Ed infine per Giuliano Crifò non fu tanto il pensiero cristiano a irrompere nelle strutture e nel diritto romano, quanto invece le categorie del diritto romano classico a vertebrare sul piano istituzionale il pensiero cristiano.
Il Papa Emerito supera queste ricostruzioni storiografiche tra loro alternative, dimostrando come l'incontro tra religione cristiana e res publica avvenne quando l'idea di "persona" e di "ragione" si saldarono non più solo in una prospettiva di "potere", ma di "cultura". La ragione per chi esercita una funzione pubblica significa innanzitutto "ragionevolezza" e consapevole rinuncia a contrapporre la legge - nell'accezione ciceroniana di "scelta" - al diritto, inteso da Feliciano Serrao come jus ossia insieme di tradizioni, consuetudini, interpretazioni e comportamenti.
Per Paolo VI "il mondo soffre per mancanza di pensiero" ed è proprio la "porta della cultura" la strada che Benedetto XVI propone a ciascuno di noi per non restare confinati dentro le angustie di un pensiero né forte, né debole, ma più semplicemente autoreferenziale. In definitiva è la cultura la via maestra per rendere la libertà strumento di giustizia.