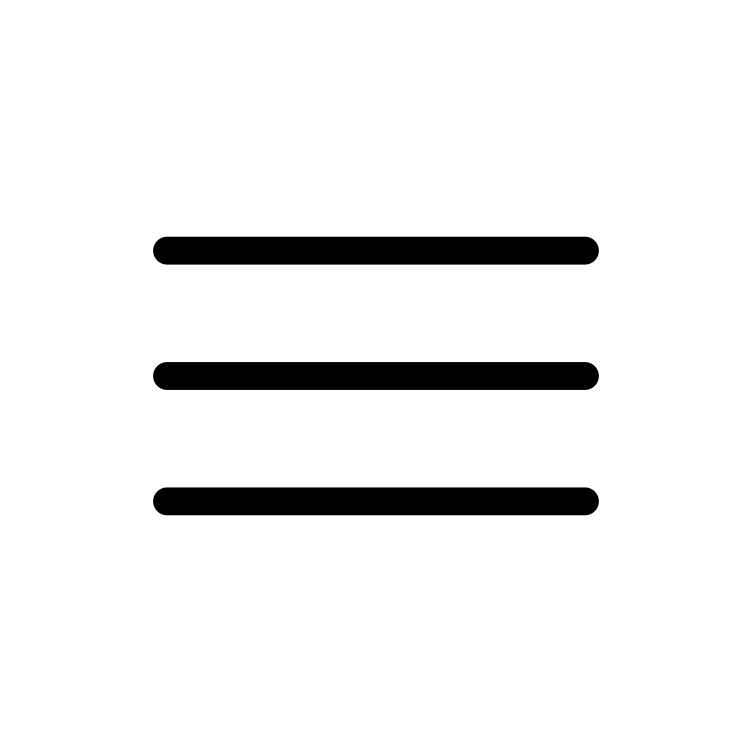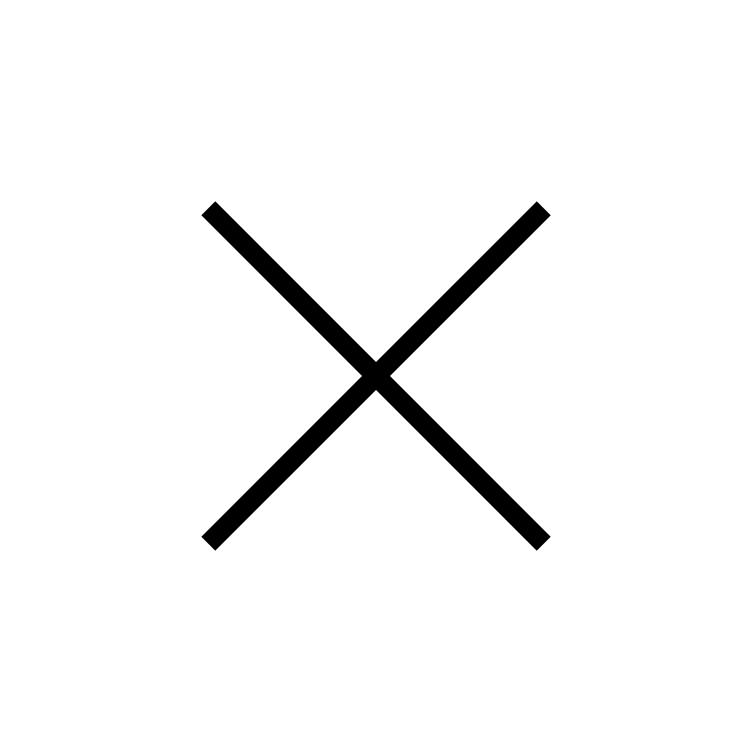Bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis
Caro professor De Sanctis, autorità, gentili ospiti,
ho accolto con vero piacere l'invito a partecipare a questa cerimonia nell'ambito del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis. Abbiamo necessità, soprattutto in momenti politici complessi come quello che stiamo vivendo, di riscoprire e di far conoscere, in primo luogo ai giovani, figure che hanno saputo coniugare ricerca intellettuale, passione civile, presenza nelle Istituzioni.
Si rivela particolarmente meritorio, quindi, il compito della Fondazione De Sanctis, volto a conservare e valorizzare il suo archivio personale e la sua biblioteca. Gli amici della Fondazione sanno bene che il loro ruolo non è quello di una mera tutela di un complesso documentale pur tanto ricco. La loro è una vera e propria missione: far diventare patrimonio collettivo il pensiero e l'opera di Francesco De Sanctis. È anche attraverso iniziative come quella di oggi, che si contribuisce a diffondere uno spirito civico, nella consapevolezza delle proprie radici e dell'importanza delle sfide future.
La biografia di Francesco De Sanctis ci restituisce, infatti, non solo un protagonista della storia culturale e politica del nostro Risorgimento, ma un modello di rigore che può e che deve essere declinato sugli scenari del tempo presente, in cui dobbiamo continuare a riconoscerci come comunità nazionale coesa e solidale e aprirci, al contempo, ad un contesto europeo che parli i linguaggi della libertà, della democrazia, dello stato di diritto.
Non è un caso che la critica letteraria di Francesco De Sanctis, anche negli anni del fascismo, sia stata ripresa e interpretata come occasione di impegno civile. Quando la violenza e il conformismo cercarono di frenare la libertà di pensiero, richiamarsi a Francesco De Sanctis significò esaltare quegli imperativi che - se vissuti con coerenza - rendono insopprimibile la coscienza umana.
Del resto, i suoi primi anni di vita testimoniano ciò: il giovane intellettuale del nostro Mezzogiorno che, contro ogni pregiudizio, erge i propri studi oltre i facili approdi per calarsi nell'arena della lotta risorgimentale.
Chi rilegge la sua "Storia della letteratura italiana", dopo essere rimasto affascinato da quell'affresco così ampio e pur sempre puntuale di vicende, di versi e di prose, non può non rimanere colpito dall'invito delle pagine finali a svolgere gli studi non nel vuoto delle accademie o nel chiuso dei salotti letterari, ma nel cuore pulsante della società e delle sue contraddizioni.
Proprio nell'ultima pagina della sua opera, Francesco De Sanctis scrive che nella ricerca degli elementi reali della sua esistenza "lo spirito italiano rifarà la sua cultura, ristaurerà il suo mondo morale, rinfrescherà le sue impressioni, troverà nella sua intimità nuove fonti di ispirazione [...] non come idee brillanti, viste nello spazio che gli girino intorno, ma come oggetti concreti e familiari, divenuti il suo contenuto".
Non stupisce allora che questa capacità di intrecciare pensiero e vita concreta abbiano animato la sua attività nelle Istituzioni, nelle Assemblee parlamentari dell'Italia unita e al Governo: un interprete autentico del suo tempo che impedì alla sua passione di naufragare nella sterile utopia o, viceversa, di piegarsi a compromessi umilianti.
In una sua lettera del 1875 a Virginia Basco Riccadi di Lantosca, sua ex allieva, in cui anticipa il racconto della sua campagna elettorale nel Mezzogiorno di quell'anno, De Sanctis lascia un'immagine della politica e dell'arte che non può non colpire ancor oggi: "avevo imparato più in quei paeselli che in molti libri [...] E' il mondo studiato dal vero e dal vivo e studiato da uno, che sotto i capelli bianchi serba il cuore giovane e intatto il senso morale e potente la virtù dell'indignazione. [...] Brutto segno quando si vede l'arte vivere di memorie come i vecchi e non gustare più la vita che le è intorno, senza fede e senza avvenire".
Il giovane esule che aveva sentito tutta la pesantezza del giogo borbonico, che era emigrato a Torino per vivere del proprio lavoro, rifiutando sussidi pur stanziati dal governo piemontese, fa sentire, in età ormai matura, la voce della dignità e della speranza e non smette di prestare la sua opera alla nuova Italia. Una Nazione unita territorialmente ma ancora bisognosa di contributi materiali e intellettuali che potevano essere assicurati solo dai suoi spiriti più elevati.
Chi rilegge l'opera "Viaggio elettorale", il suo diario di candidato alla Camera dei deputati a metà degli anni Settanta dell'Ottocento, coglie la desolazione di territori che non furono sufficientemente premiati dall'unificazione, ma percepisce anche il dovere ineludibile di non rinunciare al servizio per gli altri, di non accettare supinamente le condizioni del nostro Mezzogiorno come qualcosa di dato e immodificabile. Per questo, considero il suo Viaggio elettorale, di cui auspico una grande diffusione nelle nostre scuole, uno dei cardini intellettuali e morali, prima ancora che politici, del nostro meridionalismo storico, una lezione di civismo cui deve ispirarsi chiunque abbia a cuore la cosa pubblica.
Dieci anni prima di quel viaggio, Francesco De Sanctis aveva messo a fuoco con lucidità straordinaria e fermo equilibrio uno dei problemi più drammatici che aveva dovuto affrontare lo Stato unitario: il brigantaggio. Ovvero la rivolta di ampi strati popolari contro la nuova compagine istituzionale, prevalentemente di derivazione sabauda.
Scrive infatti in una corrispondenza parlamentare del 10 maggio 1864: "I colpi di stato sono una piaga peggiore di quella che pretendono di guarire. La libertà fa miracoli; e questi rimedi eroici possono esser bene la missione della nuova Camera".
E' una lezione attualissima di fronte alle sfide che le democrazie contemporanee sono chiamate ad affrontare. Si pensi alle offensive della violenza terroristica, al diffondersi dei fondamentalismi, alla presunta debolezza dello Stato di diritto. De Sanctis ci sprona ad agire senza lacerare quel tessuto di legalità e di diritti che caratterizza la moderna civiltà giuridica.
La sua scrittura diventa pedagogia civile, sforzo continuo per la diffusione della cultura, perché, come scrive nel 1873 in una riflessione sulla scuola in Irpinia: "la grande piaga dell'Italia è la distanza infinita che separa la classe colta dalla moltitudine, tanto che sembrano due mondi, l'uno fuori dall'altro, l'uno incompreso dall'altro".
Per questo la letteratura deve diventare strumento di riscatto etico e civile. Gli uomini migliori hanno il compito, che mai si esaurisce, di impegnarsi per la rigenerazione intellettuale e morale del paese.
Nello slancio della passione civile, vivificata dalla severità dell'intelletto, Francesco De Sanctis lascia il testimone della corsa alle donne e agli uomini che lo hanno seguito. Sta a noi decidere in quale posto trovarci duecento anni dopo la nascita di Francesco De Sanctis, in questa apertura del nuovo millennio: sta a noi decidere come coltivare la sua grande eredità politica, culturale, umana.
Con questo augurio e un rinnovato ringraziamento agli amici della Fondazione, sono certa che la cerimonia di oggi lascerà frutti importanti e interessanti elementi di ricerca per chi vorrà ascoltare, approfondire e impegnarsi per il nostro Paese.