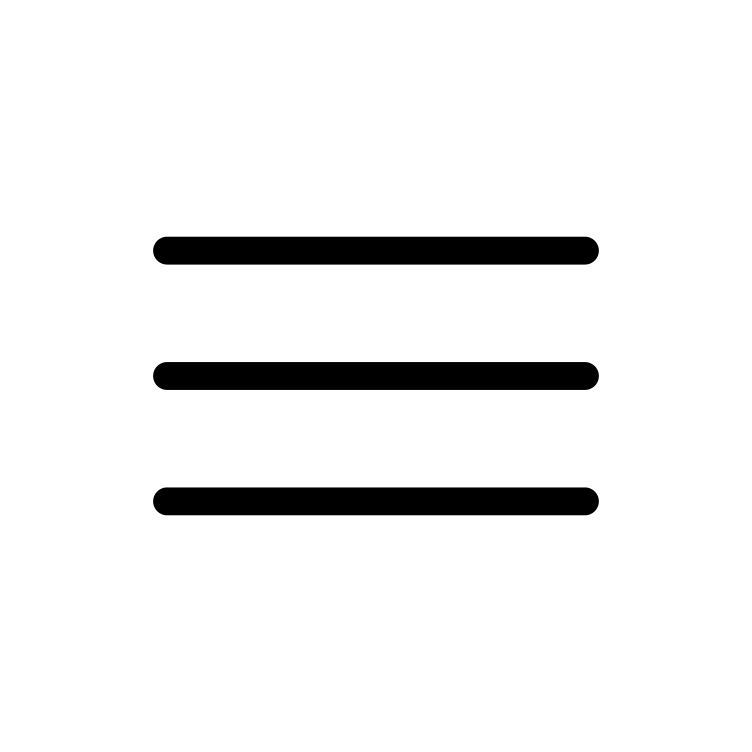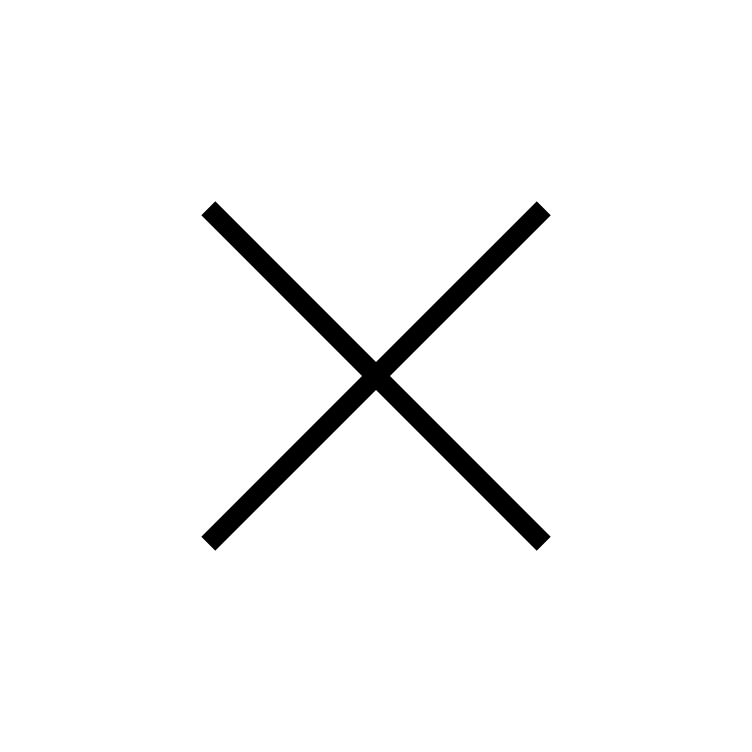Il 3 settembre 1943 il generale Castellano, delegato del capo del governo italiano, e il generale statunitense Bedell Smith, alla presenza del comandante in capo delle forze americane Eisenhower, firmarono l’armistizio di Cassibile, anche noto come armistizio “corto”, seguito dall’armistizio “lungo” firmato a Malta il 29 settembre 1943 da Badoglio e Eisenhower. L’8 settembre 1943 il presidente del Consiglio Badoglio, annunciando l’armistizio in un messaggio alla radio, invitò gli italiani a cessare le ostilità contro gli Alleati, sbarcati a Salerno nella notte tra l’8 e il 9 settembre 1943. Il 9 settembre il re Vittorio Emanuele III e Badoglio si trasferirono a Brindisi, dove rimasero fino all’11 febbraio 1944. Il Regno del Sud qui costituito divenne ufficialmente forza cobelligerante con gli Alleati il 13 ottobre 1943.
Il 3 settembre 1943 il generale Castellano, delegato del capo del governo italiano, e il generale statunitense Bedell Smith, alla presenza del comandante in capo delle forze americane Eisenhower, firmarono l’armistizio di Cassibile, anche noto come armistizio “corto”, seguito dall’armistizio “lungo” firmato a Malta il 29 settembre 1943 da Badoglio e Eisenhower. L’8 settembre 1943 il presidente del Consiglio Badoglio, annunciando l’armistizio in un messaggio alla radio, invitò gli italiani a cessare le ostilità contro gli Alleati, sbarcati a Salerno nella notte tra l’8 e il 9 settembre 1943. Il 9 settembre il re Vittorio Emanuele III e Badoglio si trasferirono a Brindisi, dove rimasero fino all’11 febbraio 1944. Il Regno del Sud qui costituito divenne ufficialmente forza cobelligerante con gli Alleati il 13 ottobre 1943.
I reparti dell’esercito italiano rimasti a Roma si opposero all’avanzata dei tedeschi, comandati da Kesselring, anche grazie all’aiuto della popolazione locale: gli schieramenti si fronteggiarono nella battaglia di Porta San Paolo tra il 9 e il 10 settembre 1943, ma il tenente colonnello Giaccone dovette firmare la resa e rassegnarsi all’occupazione di Roma da parte dell’esercito tedesco. Il conte Calvi di Bergolo trattò perché Roma fosse considerata città aperta.
Il 9 settembre 1943 fu costituito dai partiti antifascisti il Comitato di liberazione nazionale (Cln) per organizzare la Resistenza; fu presieduto da Ivanoe Bonomi. Il Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia (Clnai) sorse anch’esso il 9 settembre 1943 e fu presieduto da Ferruccio Parri.
Il 12 settembre 1943 Mussolini era stato liberato dalla prigionia a Campo Imperatore sul Gran Sasso e condotto in Germania dai paracadutisti tedeschi. Rientrato in Italia poco dopo, il 23 settembre 1943 costituì a Salò la Repubblica sociale italiana (Rsi), i cui confini geografici coincidevano pressappoco con il territorio occupato dai tedeschi; infatti i territori dell’Alto Adige, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia furono annessi direttamente alla Germania.
Sempre nelle giornate di settembre si verificarono numerosi episodi di resistenza nei confronti degli ex alleati, ora invasori: tra il 13 e il 24 settembre, i soldati della divisione Acqui furono uccisi a Cefalonia dalle truppe naziste perché si erano opposti al tentativo di disarmo da parte dei tedeschi.
Il 27 settembre 1943 la popolazione di Napoli combatté contro i nazifascisti fino all’ingresso degli Alleati, che poterono entrare nella città liberata il 1° ottobre 1943. Furono le cosiddette quattro giornate di Napoli.
Il 16 ottobre 1943 la polizia nazista di Kappler arrestò a Roma 2091 ebrei romani e li deportò nei campi di sterminio in Germania e in Polonia. Gli arresti e le deportazioni continuarono nei mesi successivi. Dall’Italia tra il 1943 e il 1945 furono deportati più di 8.500 ebrei. Il senatore del Regno Elio Morpurgo, ormai anziano e malato, fu prelevato con violenza dall’ospedale civile di Udine e morì durante il viaggio di deportazione nei pressi del Tarvisio. Le sue spoglie non furono più ritrovate. Con la legge 20 luglio 2000, n. 211, il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è divenuto per legge il Giorno della memoria, in ricordo dello sterminio di milioni di ebrei nei campi di concentramento nazifascisti e delle persecuzioni patite dal popolo ebraico e da coloro che furono vittime dell’oppressione nazifascista.
Anche la principessa Mafalda di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele III, arrestata dai nazisti il 22 settembre 1943, morì il 29 agosto 1944 nel campo di concentramento di Buchenwald.
In Istria furono compiuti massacri da parte delle forze di Tito tra il 1943 e il 1945 contro gli italiani, tra i quali anche il senatore del Regno Riccardo Gigante. Con la legge 30 marzo 2004, n. 92, è stato istituito il Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. A Boves in Piemonte fu compiuto un eccidio da parte dei nazisti il 19 settembre 1943; tra il 31 dicembre 1943 e il 3 gennaio 1944 la comunità di Boves fu sottoposta a numerose rappresaglie e il paese infine incendiato.
Sulle zone montuose dell’Italia settentrionale si svolse la guerriglia partigiana contro le truppe nazifasciste, mentre l’esercito degli Alleati, al comando del generale statunitense Clark e del generale britannico Montgomery, risaliva lungo la penisola. Tra il 17 e il 19 ottobre 1943 a Lecco si combatté una sanguinosa battaglia tra partigiani e reparti tedeschi.
Nelle città italiane si costituirono i Gruppi di azione patriottica (Gap), nelle campagne le squadre di azione partigiana (Sap) dall’autunno del 1943. Si ricordano a Milano le brigate Garibaldi (comunisti) nel novembre 1943, le brigate Giustizia e Libertà (azionisti) nel febbraio 1944, brigate Matteotti (socialisti), e le brigate del popolo e le Fiamme verdi (gruppi cattolici).
Nell’inverno del 1943-1944 i nazifascisti continuarono a perpetrare stragi efferate: l’eccidio delle Fosse Ardeatine, il 24 marzo 1944, nel quale il comandante Kappler fece trucidare 335 persone, soprattutto ebrei e antifascisti, per rappresaglia dopo l’attacco partigiano (Gap), compiuto il 23 marzo 1944 a via Rasella a Roma, a una colonna di militari nazisti.
A seguito del processo di Verona del gennaio 1944 contro i gerarchi fascisti che avevano votato l’ordine del giorno contro Mussolini del 25 luglio 1943, Galeazzo Ciano ed Emilio De Bono furono condannati a morte e fucilati l’11 gennaio 1944.
Il senatore del Regno Giovanni Gentile fu ucciso il 15 aprile 1944 in un attentato dei Gap di Firenze.
Alla conferenza di Mosca (19 ottobre-3 novembre 1943) tra i ministri degli esteri delle potenze alleate (Regno Unito, Usa e Urss) fu riconosciuto il diritto del popolo italiano di scegliere i propri ordinamenti costituzionali.
Il 16 gennaio 1944 il generale Eisenhower assunse il comando supremo delle forze alleate in Europa. Dopo lo sbarco di Anzio il 22 gennaio 1944, le truppe angloamericane si attestarono ai piedi della linea Gustav sino al mese di maggio. L’abbazia di Montecassino fu distrutta durante un bombardamento alleato il 15 febbraio 1944.
Il 1° marzo 1944 uno sciopero generale fu indetto nei più importanti centri industriali del Nord.
Nel territorio liberato furono svolti i congressi dei partiti. La Democrazia cristiana svolse tre congressi: il 16 dicembre 1943 a Caltanissetta, dal 27 al 29 gennaio 1944 a Bari, dal 16 al 18 aprile 1944 a Napoli. Il 28 e il 29 gennaio 1944 si svolse a Bari il congresso dei Comitati di liberazione. L’11 aprile 1944 al comitato del Partito comunista partecipò Palmiro Togliatti, ritornato da Mosca.
Il 16 marzo 1944 Vittorio Emanuele III comunicò la decisione di abdicare e nominare il figlio Umberto luogotenente generale del Regno, dopo la liberazione di Roma. Il 22 aprile 1944 fu costituito a Salerno, dove dall’11 febbraio 1944 era stato trasferito il governo italiano, il secondo governo Badoglio, che durò fino all’8 giugno 1944, con l’appoggio dei partiti del Cln.
Badoglio, con regio decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, sostituì la denominazione di capo del governo con la denominazione di presidente del Consiglio, ripristinando la dizione dell’epoca liberale. Con la svolta di Salerno si rinviò alla fine della guerra la scelta tra repubblica e monarchia e fu costituito il primo governo di unità nazionale.
Il senatore del Regno Carlo Sforza, perseguitato a lungo dal fascismo, fu nominato alto commissario per le sanzioni contro il fascismo e rivestì tale ruolo dal 22 aprile 1944 al 10 dicembre 1944. I senatori del Regno Benedetto Croce e Carlo Sforza furono ministri nel secondo Governo Badoglio e nel successivo governo Bonomi, in cui ricoprì la carica di ministro anche il senatore del Regno Alessandro Casati.
Il 3 giugno 1944 fu firmato il patto di Roma per l’unità sindacale da Giuseppe Di Vittorio, Achille Grandi, Bruno Buozzi: il 9 giugno fu costituita la Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) e il 28 agosto le Associazioni cristiane dei lavoratori (Acli). Il primo congresso della Cgil si svolse a Napoli dal 28 gennaio al 1° febbraio 1945. Il primo congresso delle Acli, i cui delegati furono ricevuti da papa Pio XII, si svolse dall’8 all’11 marzo 1945.
L’11 maggio 1944 le forze alleate anglo-americane iniziarono a Cassino l’offensiva che il 18 maggio portò allo sfondamento della linea Gustav. Il 4 giugno 1944 le truppe tedesche abbandonarono Roma. I partigiani continuarono le azioni di guerriglia per aiutare l’avanzata degli Alleati, mentre le truppe naziste si allinearono sulla linea gotica, lungo l’Appennino settentrionale.
Il 5 giugno 1944 Vittorio Emanuele III nominò Umberto di Savoia luogotenente generale del Regno. Dopo lo sbarco degli Alleati in Normandia il 6 giugno 1944, Bonomi costituì il suo primo Governo (18 giugno 1944-10 dicembre 1944). Con decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, fu stabilita la convocazione dell’Assemblea costituente al termine del conflitto e fu attribuito al Consiglio dei ministri il potere di emanare provvedimenti con forza di legge. Il governo Bonomi abolì la pena di morte nel codice penale (decreto-legge luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224). Il 15 luglio 1944 il governo poté trasferirsi finalmente da Salerno a Roma.
Nell’estate 1944 furono liberate le città dell’Italia centrale: Perugia il 20 giugno 1944, Siena il 3 luglio 1944, Firenze il 7 settembre 1944. La Repubblica di San Marino fu liberata il 20 settembre 1944, Rimini il 21 settembre, Forlì il 9 novembre, Ravenna il 4 dicembre 1944. Il 7 dicembre 1944 fu firmato l’accordo tra il Clnai e gli Alleati.
In Francia il 26 agosto 1944 era stata liberata Parigi. In Germania, il 20 luglio 1944, era fallita la congiura del colonnello Stauffenberg contro Hitler. In Polonia il 1° agosto 1944 Varsavia era insorta contro l’oppressione dell’occupante nazista, che l’anno precedente aveva perpetrato l’efferato rastrellamento della popolazione ebraica (22-23 gennaio 1943) e represso nel sangue la disperata resistenza degli ebrei nel ghetto di Varsavia (19 aprile-16 maggio 1943), poi interamente distrutto. Nell’Italia centrosettentrionale furono compiute numerose stragi ed eccidi efferati da parte delle truppe nazifasciste: si ricordano Civitella della Chiana (29 giugno 1944), Fossoli (12 luglio 1944), Sant’Anna di Stazzema (12 agosto 1944), Marzabotto (29 settembre-5 ottobre 1944). Numerosi partigiani furono uccisi e trucidati: tra questi Giancarlo Puecher (21 dicembre 1943), Dante di Nanni (18 maggio 1944), Eugenio Colorni (30 maggio 1944), Duccio Galimberti (3 dicembre 1944), i sette fratelli Cervi (28 dicembre 1943); Bruno Buozzi e altri prigionieri italiani furono uccisi dalle truppe nazifasciste nella località La Storta nei pressi di Roma il 4 giugno 1944, il giorno stesso in cui Roma veniva liberata.
Il 13 novembre 1944 il generale britannico Alexander, comandante nel Mediterraneo, ordinò una sosta nelle operazioni militari lungo la linea gotica. Bonomi formò il suo secondo governo (12 dicembre 1944-19 giugno 1945).
Dal 16 dicembre 1944 al 31 gennaio 1945 fallì l’offensiva tedesca nelle Ardenne, mentre Berlino venne bombardata massicciamente tra il febbraio e il marzo 1945. Dopo l’offensiva sulla Vistola, iniziata il 12 gennaio 1945, i sovietici entrarono a Varsavia (17 gennaio 1945) e a Cracovia (18 gennaio). Il 27 gennaio 1945, l’esercito sovietico entrò nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Il 20 gennaio 1945 l’Ungheria firmò l’armistizio con l’Unione Sovietica. Tra il 4 e l’11 febbraio 1945 Churchill, Roosevelt e Stalin si incontrarono a Yalta per gettare le basi della ricostruzione, affrontare il problema della sistemazione della Germania e definire le aree di influenza.
Nel Pacifico il 19 febbraio 1945 le truppe americane sbarcarono a Ivo Jima e il successivo 1° aprile 1945 a Okinawa. In Europa il 7 marzo 1945 le truppe angloamericane riuscirono a superare il Reno in Germania, mentre il 13 aprile 1945 le truppe sovietiche entrarono a Vienna.
Nell’Italia settentrionale una serie di scioperi furono organizzati il 18 e il 19 aprile 1945. Presso Argenta (Ferrara), gli alleati superarono la linea gotica il 18 aprile 1945 e il 21 aprile 1945 fu liberata Bologna. Il Clnai assunse il 25 aprile 1945 i poteri civili e militari e proclamò l’insurrezione generale nell’Italia settentrionale: il 25 aprile furono liberate Milano e Genova, insorta il 23 aprile 1945; il 26 aprile fu liberata Torino; il 28 aprile furono liberate Aosta, Piacenza, Bergamo, Venezia. Il 25 aprile 1945 è stato istituzionalizzato come anniversario della Liberazione con decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185, e con legge 27 maggio 1949, n. 260. Il 27 aprile 1945 Mussolini e Claretta Petacci furono catturati a Dongo dai partigiani e uccisi a Giulino di Mezzegra il 28 aprile. I cadaveri furono esposti a piazzale Loreto a Milano.
Il 27 aprile 1945 gli americani entrarono a Dresda, il 2 maggio 1945 l’armata rossa entrò a Berlino, dove il 30 aprile 1945 Hitler si era tolto la vita. Il 2 maggio 1945 furono dichiarate terminate le ostilità in Italia e i tedeschi firmarono la resa incondizionata nei confronti delle truppe alleate nella Reggia di Caserta. Il 7 maggio 1945 a Reims i tedeschi firmarono la resa incondizionata alla presenza del generale Eisenhower. Tra l’8 e il 9 maggio 1945 terminarono le ostilità in Europa.
Il conflitto mondiale comportò le tragiche devastazioni dovute all’esplosione delle bombe atomiche su Hiroshima (6 agosto 1945) e Nagasaki (9 agosto 1945). Il 2 settembre 1945 fu firmata in ultimo anche la resa giapponese.
Il 26 giugno 1945 alla conferenza di San Francisco fu firmato lo Statuto dell’Organizzazione delle Nazioni unite, nata con lo scopo di assicurare la pace e evitare il ricorso alle armi. Tra il 17 luglio 1945 e il 2 agosto 1945 si svolse la conferenza di Potsdam sull’assetto dell’Europa fra il primo ministro inglese Attlee, subentrato a Churchill, il presidente statunitense Truman, subentrato a Roosevelt, morto l’11 aprile, e il presidente sovietico Stalin.
Nel nuovo governo italiano, costituito da Ferruccio Parri (21 giugno 1945-8 dicembre 1945) fu ministro anche il senatore del Regno Federico Ricci. Il governo Parri istituì il ministero della Ricostruzione (decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378), dell'Alimentazione (decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379) e dell'Assistenza post-bellica (decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380). Furono emanati i decreti per l’istituzione della Consulta nazionale, in particolare il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146. Con decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, fu istituito il ministero per la Costituente, poi soppresso con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 54.
La convocazione dell'Assemblea Costituente fu prevista dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151. Nel 1945 l’Italia fu ammessa all’United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Unrra), organizzazione costituita dagli Alleati nel 1943 per il soccorso e la ricostruzione. Il 10 dicembre 1945 Alcide De Gasperi costituì il suo primo governo, durato in carica fino al 1° luglio 1946. Furono emanate le norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente con decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per la convocazione dei comizi elettorali. Il diritto di voto era stato esteso alle donne con decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23. Si stabilì che il referendum costituzionale e le elezioni per l’Assemblea costituente avvenissero contemporaneamente (decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98). Con decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219, furono emanate le norme per lo svolgimento del referendum istituzionale e per la proclamazione dei risultati. Furono emanate le disposizioni temporanee per la Corte suprema di cassazione (decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 353). Il 9 maggio 1946 Vittorio Emanuele III abdicò al figlio Umberto II. Il 2 giugno 1946 si svolsero le elezioni politiche e il referendum istituzionale. Il 2 giugno, data di fondazione della Repubblica Italiana, fu dichiarata festa nazionale con la legge 27 maggio 1949, n. 260.
Il 10 giugno 1946 i risultati del referendum istituzionale furono proclamati dalla Corte di cassazione in seduta solenne presso la Sala della lupa nel Palazzo di Montecitorio. Alcide De Gasperi assunse il ruolo di capo provvisorio dello Stato in sostituzione di Umberto II, che si recò in esilio. Il 25 giugno 1946 a Montecitorio si riunì l’Assemblea costituente, presieduta da Giuseppe Saragat, poi dimessosi e sostituito da Umberto Terracini l’8 febbraio 1947. Con decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, fu proclamata un’amnistia generale per reati comuni, politici e militari. Il 28 giugno 1946 Enrico De Nicola fu eletto capo provvisorio dello Stato dall’Assemblea costituente. Il 15 luglio 1946 l’Assemblea costituente istituì la commissione per la Costituzione (commissione dei 75) per la redazione del testo costituzionale. Il 19 luglio 1946 il presidente Saragat nominò su delega dell’Assemblea i componenti della commissione, presieduta da Meuccio Ruini dal 20 luglio 1946. Il 10 agosto 1946 il presidente del Consiglio De Gasperi intervenne a Parigi, dove il 10 febbraio 1947 fu firmato il trattato di Pace (la ratifica avvenne con la legge 2 agosto 1947, n. 811). Trieste dal 15 settembre 1947 fu divisa in una Zona A, amministrata dagli Alleati fino al 5 ottobre 1954, data in cui ritornò all’Italia, e una Zona B, amministrata dalla Iugoslavia. Con gli accordi di Osimo del 10 novembre 1975 fu definita la linea di confine. L’Italia partecipò agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (ratifica con la legge 23 marzo 1947, n. 132). Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea costituente votò a scrutinio segreto la Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola. Il testo fu controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi e dal presidente dell'Assemblea costituente Umberto Terracini, con il visto del ministro Guardasigilli Giuseppe Grassi. La Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Il 18 aprile 1948 fu eletto il primo Parlamento repubblicano, apertosi l’8 maggio 1948. L’11 maggio 1948 Luigi Einaudi fu eletto presidente della Repubblica.